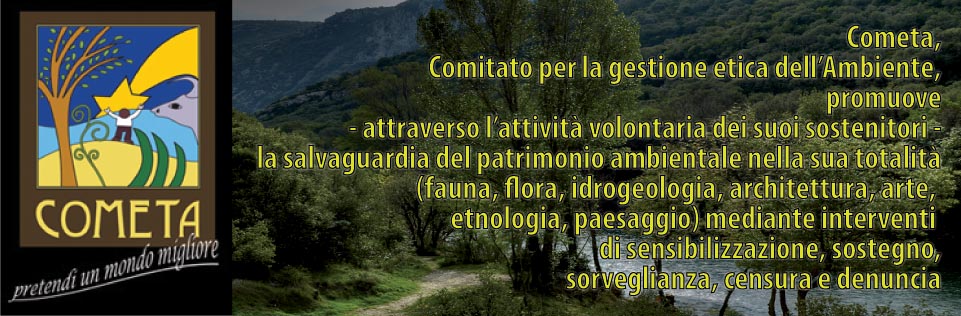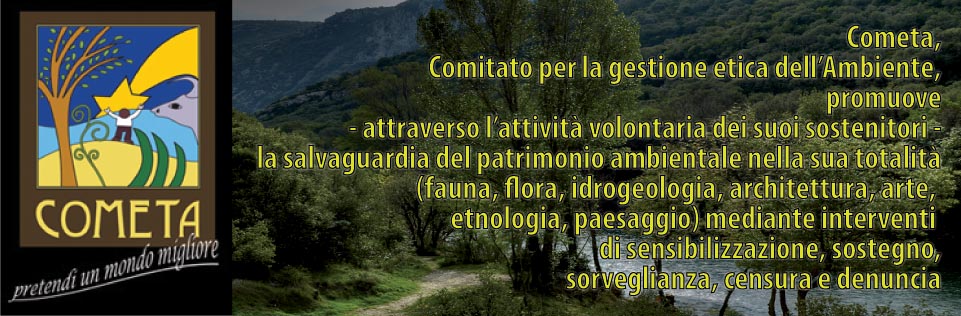Alziamo gli occhi al cielo, guardiamo le stelle. Contiamole una per una. Se siamo in aperta campagna, lontano dalle luci della città, possiamo arrivare a 2.500 e se ci troviamo in alta montagna fino a 5.000.
Ma se fossimo un membro della popolazione Pirahã[1] diremmo semplicemente che le stelle che vediamo sono baàgiso, cioè, semplicemente, molte.
L'obiettivo di questo calendario è dimostrare che anche noi, homini sapientes, quando ci troviamo di fronte a numeri molto grandi o molto piccoli, siamo nella stessa condizione dei Pirahã: la quantità ci sfugge.
La percezione del numero di oggetti che vediamo, la capacità di riconoscerne almeno approssimativamente la quantità (molti / pochi), è un tratto evolutivo che accumuna umani e animali. Per molti esseri viventi riconoscere la dimensione numerica è un vantaggio: per una preda essere attaccata da uno solo, da pochi o da molti predatori determina differenze nel comportamento, che spesso significano vivere o soccombere; ma anche per il predatore attaccare un singolo individuo o un piccolo gruppo piuttosto che un branco può comportare la differenza tra nutrirsi o restare a digiuno. Molti uccelli sono in grado di capire se il loro nido è stato saccheggiato perché possono distinguere il numero delle uova rimaste dopo l'ultima volta che hanno fatto ritorno a casa.
Gli etologi distinguono due modalità di percezione del numero di oggetti: il subitizing (parola che in italiano potrebbe essere tradotta con l'orrendo termine subitizzazione) ovvero la percezione immediata del numero esatto di oggetti, e l'ANS (approsimate number system), cioè una sorta di stima del numero di oggetti, che si potrebbe riassumere con la percezione della differenza tra pochi e molti.
Il subitizing è limitato: nessun animale, inclusi i primati e l'infante umano, è in grado di distinguere a colpo d'occhio più di 4 oggetti, salvo alcuni uccelli (come corvi e pappagalli) che sanno contare - per così dire - fino a 6 o 7; i nostri amici domestici, cani e gatti, non vanno oltre 3. L'ANS è diffuso tra le scimmie, i cani e gli elefanti, ma praticamente tutti i predatori sono in grado di capire se il branco che stanno per assalire è poco o molto numeroso. Dei pesci si sa che sono in grado di distinguere tra banchi che siano almeno uno doppio dell'altro.
Ovviamente nessun animale non umano ha sviluppato il concetto astratto di numero, che anche per l'uomo è cosa recente.
Gli antropologi distinguono precisi momenti che hanno consentito all'essere umano di entrare in possesso dei numeri come li intendiamo al giorno d'oggi, e che ripercorrono il cammino dell'infante umano verso l'acquisizione del processo di calcolo. Parafrasando Haekel potremmo dire che, in questo caso, l'ontogenesi (lo sviluppo individuale) ripercorre la filogenesi (lo sviluppo della specie)[2].
Il caso citato delle popolazioni amazzoniche che possiedono solo la modesta capacità del subitizing dimostra che probabilmente le popolazioni di cacciatori-raccoglitori che hanno occupato il nostro pianeta per quasi due milioni di anni, dai tempi dell'homo erectus fino a poche decine di migliaia di anni or sono, non andavano oltre quantità come uno, due, tre, pochi, molti. Il fatto che il subitizing e l'ANS siano tratti comuni tra molti animali ci consente di affermare che il saper riconoscere quantità piccole e valutare qualitativamente quantità grandi è un tratto innato, un prodotto dell'evoluzione. Possiamo dire che questo è il passo zero del cammino di avvicinamento dell'uomo al numero.
Ma cosa è accaduto quando qualche piccolo gruppo di cacciatori-raccoglitori nomadi decise di fermarsi e di iniziare ad allevare gli animali anziché cacciarli o, meglio ancora, quando due di queste comunità decisero di scambiarsi i loro prodotti, di commerciare?
Esperimenti condotti su infanti di uomo e primati dimostrano che esiste un'altra abilità innata, almeno in questi mammiferi superiori. E' la capacità di accoppiare oggetti nel senso intuitivo di "uno a uno", ovvero - come diremmo nel linguaggio della matematica - il riconoscimento della corrispondenza biunivoca, che negli infanti compare verso i due-tre anni di età. La comprensione dell'uso della corrispondenza biunivoca rappresenta il primo passo del cammino perché conferisce la capacità di contare senza conoscere i numeri.
L'ulteriore livello dello sviluppo dell'abilità numerica compare nel bambino verso i 4-5 anni di età, quando comincia a comprendere la successione numerica e i concetti insiemistici di aggiungere e togliere (ovvero a intuire le operazioni di somma e sottrazione). Parallelamente, sul piano collettivo, si svilupparono vasti sistemi numerici, in India, a Babilonia, nell'Egitto e altrove, i numeri cominciano ad avere un nome e una rappresentazione; i calcoli - sotto il potente e definitivo impulso del commercio e dello sviluppo della moneta - diventano complicati, ma il loro uso resta puramente pratico, i numeri vivono ancora solo in quanto "numeri di cose", "numeri di dare e avere".
Manca il grande salto dell'astrazione, del concepimento di numeri che vivono di vita propria: adesso i sapientes sono in grado di contare dieci capre e dieci vasi di ceramica, anzi sanno prolungare la successione fino a migliaia e milioni di oggetti, ma cosa c'è in comune tra questi dieci capre e dieci vasi? nasce - in Grecia, nel VI secolo a.C. - il numero "astratto", il dieci come unico elemento comune ai due gruppi di capre e di vasi, è l'idea platonica di numero come ente perfetto che si riflette nella realtà delle dieci capre come in qualunque altro insieme di oggetti che si possono contare.
Ma, e questa è la domanda che pone il nostro calendario, noi - homini sapientes, che usiamo i numeri migliaia di volte al giorno, direttamente o indirettamente attraverso tutti i meccanismi meccanici ed elettronici che la tecnologia ci ha messo a disposizione, noi che letteralmente dipendiamo dai numeri - siamo sicuri di essere così lontani dai nostri antenati preistorici e dai Pirahã contemporanei?
il fatto è che i numeri che usiamo quotidianamente appartengono a un range molto limitato.
Temperature, distanze, quote, profondità ci sono familiari; il PIL di uno stato è uno dei valori più grandi con cui abbiamo a che fare; sappiamo che la Luna dista dalla Terra circa 400.000 km, il Sole 150 milioni di km., la stella più vicina, Proxima Centauri, poco più di 4 anni luce. Tutto questo ci è ben chiaro, ma spesso, per provare stupore di fronte ai grandi (e piccoli) numeri che la Natura ci mette a disposizione, siamo costretti a riportare le misure alla dimensione umana: se esistesse un'autostrada Terra-Luna per percorrerla (supponendo che anche lì abbiano imposto un limite di velocità di 130 km/h) basterebbero poco più di 4 mesi; alla stessa velocità per arrivare al Sole ci vorrebbero 132 anni, tutto considerato periodi di tempo che ancora appartengono alla nostra quotidianità. Ma raggiungere Proxima Centauri richiederebbe più di 35 milioni di anni.
Insomma, se vogliamo veramente apprezzare i numeri, se vogliamo veramente stupirci della verità che portano con sé, ogni tanto dobbiamo soffermarci a immaginare il loro ordine di grandezza, confrontandolo con ciò che ci sta vicino. E' inverno e abbiamo freddo, ma - poco sopra la nostra testa - la notte appena fuori dall'atmosfera è ben più fredda: 150°C sotto zero; abbiamo caldo e il termometro segna 40° ma basta scendere in un buco profondo una decina di km (come il pozzo scavato dai russi nella penisola di Kola tra il 1970 e il 1989) e ci troviamo a +300°, il triplo della temperatura dell'ebollizione dell'acqua.
Anche volendo restare sul nostro piccoli Pianeta, passeggiando tra i numeri miseri della scala terrestre[3], forse dovremmo riflettere che homo è una tra quasi due milioni di specie animali note (e probabilmente altrettante ancora da classificare) e almeno mezzo milione di specie vegetali; che di virus ne sono stati classificati circa 10.000, ma si presume che ne esistano da 10 a 100 milioni. E' vero, i virus non sono esattamente materia vivente, ma nel suolo, negli oceani, dentro il corpo degli animali (uomo incluso) vi sono più particelle virali di quante siano le stelle dell'universo osservabile (100 miliardi di trilioni), tutte in trepida attesa di incontrare una cellula entro cui riprodursi.
Quando abbiamo a che fare con grandezze molto grandi o molto piccole i numeri della nostra quotidianità presentano una difficoltà: sono troppo lunghi da scrivere. Il numero totale di particelle di virus sulla Terra è:
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
e la loro dimensione media è:
0,00000001 metro,
che è ancora una lunghezza elevata in confronto al raggio di un protone, ovvero:
0,0000000000000001 metro.
Per questa ragione già nel Rinascimento qualcuno ebbe la bella pensata di rappresentare i numeri più grandi interponendo dei punti ogni tot cifre. Nicolas Chuquet (1445-1488) propose che ogni numero molto grande venisse rappresentato in gruppi di sei cifre, dando a ciascuno di essi un nome. Nacquero così (oltre al milione) il bilione, il trilione, etc[4].
Ma fu solo nel XIX secolo che tutto il mondo scientifico convenne sull'opportunità di indicare i grandi numeri (cui si aggiunsero anche i numeri piccoli, inferiori all'unità) come potenze di 10, dando loro anche un nome: e se i prefissi "etto-(grammo)" "chilo-(metro)" "centi-(metro)" "milli-(litro)" li impariamo fino dalla scuola elementare, altri, come "giga-byte" "nano-metro" sono entrati nel nostro lessico quotidiano solo in epoca moderna, portati dalle nuove tecnologie[5]. Occorre quindi prestare sempre molta attenzione e non dimenticare MAI che le grandezze in base 10 si scrivono in modo molto sintetico, ma se si trascura l'esponente perdiamo il senso della diversità.
Ragionare sui numeri e sulle grandezze della Natura, capirne l'effettiva dimensione, non solo ci apre la strada della conoscenza, ma anche dell'etica. Se il raggio della Terra fosse un metro, la crosta terrestre e l'atmosfera, l'unica parte del Pianeta dove si trova la vita, sarebbe alta pochi millimetri: uno spazio esiguo per una condizione unica e meravigliosa ma fragile, esposta agli insulti che ci vengono dal cielo e dalla terra sottostante, ma soprattutto esposta ai capricci di quella creatura forse divina ma certamente stolta che è l'uomo e alle ambizioni di quelle creature meno divine e più stolte che ci governano.
nell'immagine: Tobia Ravà, Moltiplicatore Naturale, 2019
[1] è una popolazione di circa 700 cacciatori-raccoglitori che si spostano lungo il Maici, un affluente del Rio delle Amazzoni. Il linguaggio dei Pirahã è privo di numeri: hòi significa uno o due, hoì sta per pochi, altrimenti gli oggetti sono baàgiso, molti. L'incapacità di contare determina tutto il pensiero e i valori della loro società: nessun Pirahã sa quanti anni ha, e il loro ricordo del passato è limitato al tempo in cui erano vivi i genitori e, al più, i nonni. Impossibilitati a pensare in chiave storica non sono in grado di conservare il cibo e non hanno potuto sviluppare i miti fondanti su cui si basa la religione, pur avendo animali guida. Un popolo felicemente materialista che ignora tutto ciò che non è tangibile. A partire dagli ultimi anni del '900 l'antropologo e linguista (che era anche missionario) Caleb Everett visse con loro per molto tempo con l'obiettivo di convertirli: racconta che i suoi interlocutori persero qualunque interesse verso la figura di Gesù quando scoprirono che Everett non lo aveva conosciuto di persona. Dal lavoro di Everett scaturirono diversi libri ma «L’unica conversione che ho ottenuto è stata la mia», come dichiarò nel 2017, quando tornò dall'Amazzonia portando con sé la convinzione che si può essere felici anche senza Dio.
Dal punto di vista dell'abilità numerica è molto interessante la vasta popolazione amazzonica (attualmente in crescita) dei Munduruku, 12.000 persone disperse in 22 villaggi. I Munduruku usano solo cinque numeri che fino al tre (pug. xep xep, ebapug) indicano quantità precise - uguali al numero delle sillabe - mentre il quattro (ebadipdip) e il cinque (pug pogbi) sono grandezze sfumate sempre maggiori, i cui stessi nomi sono ignorati da parte della popolazione.
Si stima che siano un centinaio le comunità isolate che non hanno avuto contatti (se non sporadici) con l'"uomo bianco" in Amazzonia, tra i Pigmei e i nativi australiani.
[2] la teoria della ricapitolazione di Haekel è ormai assolutamente superata. La nostra affermazione, da intendersi nel contesto culturale, ha un puro valore di sintesi
[3] le grandezze da 1 metro a 1 km vengono generalmente denominate scala umana, che è parte della cosiddetta scala terrestre, da 1 millimetro (dimensione degli insetti) a 40.000 km (circonferenza terrestre)
[4] a Chuquet non venne riconosciuto il merito di questa invenzione fino al 1880, quando la sua opera fu scoperta allo studioso Aristide Marre
[5] attenzione! il numero che nella nomenclatura anglosassone viene chiamato billion in italiano viene chiamato miliardo (= 1.000 milioni = 109 = 1 Giga), il numero che nella letteratura anglosassone viene chiamato trillion in italiano viene chiamato billione (= un milione di milioni = 1.000.000.000.000 = 1012 = 1 Tera). E' il motivo per cui conviene sempre usare la notazione 10n oppure usare gli opportuni prefissi (vedi tavola in allegato al calendario) che costituiscono lo standard in tutto il mondo