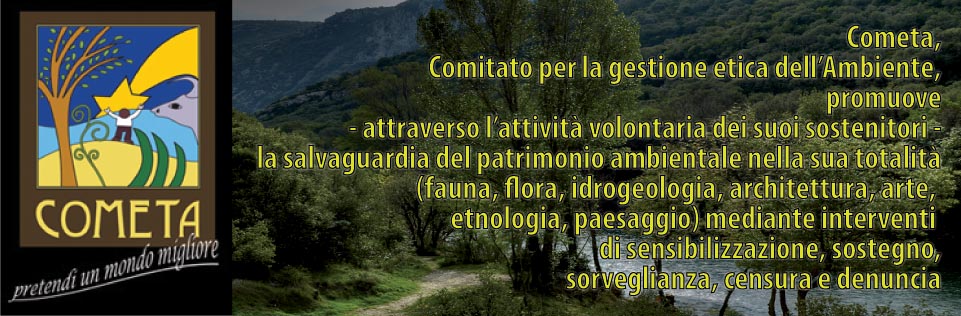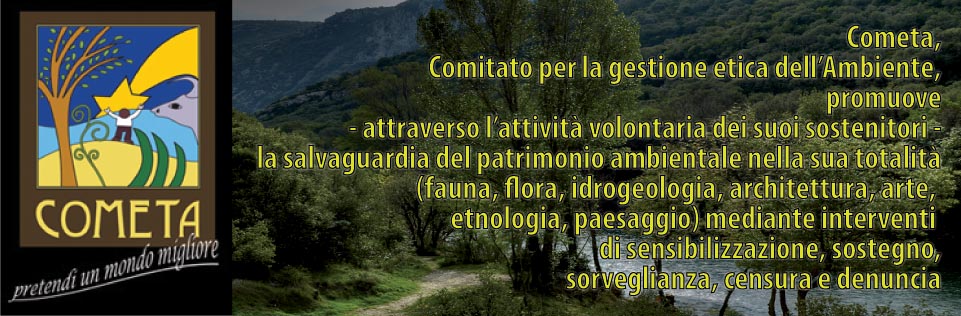Quante volte ci siamo detti, anche su queste piccole pagine, che il più grande nemico della Natura è l'uomo? Tuttavia non possiamo nascondere che l'origine di quasi tutte le grandi estinzioni che hanno travagliato il nostro pianeta è stata, almeno finora, la Terra stessa, il suo sottosuolo e la sua atmosfera.
L'uomo ha creato esplosivi potenti e micidiali, ma quando Gaia dà un colpo di tosse scatena un'energia migliaia di volte superiore alla totalità di tutti gli ordigni, nucleari e non, inventati dall'uomo, quelli già usati e quelli che arrugginiscono nei magazzini militari: il terremoto che colpì l'Oceano Indiano al largo di Sumatra il 26 dicembre 2004 (magnitudo 9.1-9.3) e il conseguente tsunami, con onde alte fino a 50 metri e velocità - nei pressi dell'epicentro - superiori a 500 km all'ora, hanno rilasciato un'energia pari a quella di 45mila-90mila bombe atomiche come quelle esplose su Hiroshima e Nagasaki.
I mezzi di comunicazione hanno dedicato largo spazio alle vittime della catastrofe di Sumatra (che uccise 230.000 persone e costrinse all'allontanamento da 3 a 5 milioni di abitanti), ma ben poco alla quasi totale sopravvivenza degli elefanti e delle altre specie selvatiche che fuggirono all'interno del territorio prima dell'arrivo delle onde[1]. Chi fu in grado di osservare e interpretare i loro movimenti si salvò[2].
Tra gli eventi terrestri dai quali non possiamo difenderci, i terremoti sono i più impressionanti: possono uccidere migliaia di persone in tempi brevissimi e avere effetti secondari (tipicamente il maremoto, ma anche incendi ed epidemie) che ne completano l'opera devastatrice[3]. Contro il terremoto non esiste salvaguardia: non siamo in grado di prevedere se e dove colpirà e con che forza.
Tuttavia sappiamo che i nostri amici animali possono darci qualche avvertimento: fin dall'antichità molte cronache provenienti da tutte le parti del mondo ci raccontano di animali che hanno saputo interpretare i movimenti della Terra.
Strabone narra nella sua Geografia (VIII, 7, 2) che nessuno delle migliaia di abitanti di Helike sopravvisse al terremoto dell'inverno del 373 a.C. mentre topi, serpenti, donnole, insetti abbandonarono la città qualche giorno prima della catastrofe[4].
All'altro capo del mondo possiamo trovare testimonianze altrettanto antiche sul comportamento degli animali prima del terremoto: le cronache ufficiali Tang e Ming, che riferiscono numerosi terremoti avvenuti in Cina a partire dal 206 a.C., ci raccontano di cani e cavalli agitati, serpenti e topi che abbandonavano le loro tane in pieno inverno. Il libro XII del Mahabharata indiano raccoglie analoghe vicende tra il IV secolo a.C. e il I secolo d.C.. I rersoconti giapponesi del periodo Heian (794–1185 d.C.) riportano di pesci che saltano fuori dall'acqua e di uccelli marini agitati. Analoghi fatti si ritrovano nelle cronache medioevali del Tibet e della Persia.
Questi sono eventi molto lontani nel tempo, spesso narrazioni di seconda mano, su cui pesa il dubbio che si siano innestate credenze popolari: come sempre i fatti reali del passato si nascondono nella nebbia delle dicerie e delle leggende[5].
Le vicende si fanno meno confuse a mano a mano che ci avviciniamo alla nostra epoca.
La prima certificazione oggettiva di comportamenti anomali degli animali prima e durante un movimento tellurico risale alla metà del '700, quando il marchese di Pombal, dopo il terremoto che distrusse Lisbona la mattina del giorno di Ognissanti del 1755[6], organizzò un'inchiesta a tappeto, distribuendo alle autorità locali e alle parrocchie un questionario di 13 domande, tra cui la domanda 11: "Gli animali hanno mostrato segni particolari prima o durante il terremoto?". Molte risposte riportarono comportamenti anomali prima delle scosse: cani che ululavano senza motivo, cavalli e bovini che cercavano di scappare dalle stalle, animali domestici che si muovevano in modo caotico, pollame incapace di calmarsi.
A partire dall'inizio del diciannovesimo secolo le testimonianze si moltiplicano, coinvolgendo anche altre specie, come gli orsi che diventarono particolarmente attivi prima di un terremoto in Kamchatka. Il Los Angeles Times del 1906 dedica molto spazio al comportamento degli animali durante il terremoto di San Francisco del 18 aprile 1906, ricordato nel libro di Will Irwin La città che fu e in alcuni film.
Il caso che più ha contribuito al consolidamento dell'idea che alcuni animali siano in possesso di capacità predittiva dei fenomeni sismici (oltre a quello di Sumatra citato in apertura) è il terremoto di Haicheng, in Cina, del 4 febbraio 1975, che attualmente viene considerato l'unico terremoto realmente previsto e di cui fu dato un ordine preventivo di evacuazione (che, si stima, salvò la vita di 150.000 persone) interpretando solo deboli segnali strumentali, impercettibili dall'uomo, e valutando il comportamento degli animali: serpenti emersi in massa dal letargo invernale, cani che ululavano, ratti e altri animali che si muovevano in modo insolito.
In Italia disponiamo di un'autentica e verace area test: i Campi Flegrei, dove da sempre si osservano comportamenti inattesi degli animali durante gli episodi di bradisismo (cani e gatti che rifiutano di entrare nelle abitazioni, voli caotici degli uccelli; ovviamente moria di pesci e molluschi a causa delle improvvise emissioni gassose, ma quest'ultimo non è un segno premonitore, ma una prova dell'evento in corso).
Nonostante la frequenza delle testimonianze, gli scienziati restano cauti nell'attribuire agli animali capacità previsive dei fenomeni tellurici, soprattutto perché i tempi di anticipazione degli eventi appaiono molto variabili e poco dipendenti dalla loro intensità (l'unico caso noto di evacuazione basata - tra l'altro - sul comportamento animale è quello di Haicheng testé citato)[7]. Tuttavia sono in corso studi di approfondimento. In Italia i ricercatori dell'università di Perugia hanno catalogato 323 casi di comportamento inatteso di animali in seguito al terremoto de L'Aquila (6 aprile 2009); un team internazione, di cui fanno parte anche ricercatori dell'università di Camerino ha pubblicato sulla rivista Ethology un'analisi satellitare dei movimenti collettivi degli animali da allevamento in prossimità di fenomeni sismici. Studi analoghi si svolgono in altri molti Paesi.
Viceversa, se non si parla di previsioni in senso stretto, esiste accordo nella comunità scientifica sulla capacità degli animali di percepire segni anticipatori di attività tellurica. Non si tratta certo di "sesto senso", ma semplicemente del fatto che molti animali dispongono di capacità sensoriali molto più estese di quelle umane.
L'attenzione dei ricercatori è concentrata su diversi fattori che sfuggono ai sensi umani e che sono associati ai movimenti della Terra: percezione della variazione del campo elettromagnetico, rumori a bassa frequenza, alterazioni chimiche delle falde acquifere, emissioni di gas dal suolo, luci sismiche (EQL - Earth Quake Lights - "luci da terremoto") dovute alla risalita nell'atmosfera di ioni di ossigeno liberati dalla compressione delle rocce. Questi fenomeni sono associati alle cosiddette onde primarie (o onde P) che sono le prime manifestazioni del terremoto e che si propagano orizzontalmente a grande velocità (a differenza delle onde successive che si propagano verticalmente e generano i sussulti) e di norma sono avvertibili solo dai sismografi[8] e, a quanto pare, dagli animali e forse anche dalla piante.
Anche nel caso di fenomeni di origine atmosferica i nostri amici animali sono in grado di darci qualche segnale, benché più debole di quelli legati ai movimenti tellurici.
Nel settembre del 1887 il fiume Giallo straripò allagando una superficie pari a quasi la metà dell'Italia e causando la morte di un numero di persone compreso tra 1 milione e 2 milioni[9]. Tanto per questa alluvione quanto per le precedenti, le cronache riportano che, prima della piena, rane e rospi abbandonarono gli stagni e i topi fuggirono verso aree coperte. Nel 2005 i cani e i gatti di New Orleans mostrarono segni di ansia prima dell'arrivo dell'uragano Katrina, pesci e alligatori del bayou entrarono in un'attività frenetica. Analoghi casi sono stati osservati un po' dovunque e in varie occasioni, anche in Italia durante la frana del Vajont (1963), quando gli uccelli abbandonarono l'invaso nelle ore precedenti l'evento.
Per chiudere aggiungeremo che anche alcuni organismi vegetali sembrano in grado di percepire le avvisaglie dei moti tellurici, tant'è che lo stesso INVG (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha avanzato la proposta di indagare sul tema.
Ci sembra abbastanza per poter affermare che abbiamo un ulteriore debito verso gli altri esseri viventi che dividono con noi questo piccolo pianeta.
nell'immagine: San Francisco - Market Street dopo il terremoto del 18 aprile 1906
[1] Francesco Mulargia, docente di Geofisica all'università di Bologna, in una conferenza del 2011
[2] il moto ondoso colpì duramente anche le isole Andemane e Nicobare, a nord dell'epicentro. Delle cinque tribù di nativi che vi risiedono la sola popolazione devastata è stata quella dell'isola Nicobar, i cui abitanti sono coltivatori, mentre non vi furono vittime nelle tribù delle altre isole, abitate da cacciatori-raccoglitori. In un'intervista all'Interpress Service il dottor Raghavendra Rao, responsabile dell'Anthropological Survey of India, attribuisce il loro salvataggio all'attenzione posta dalle popolazioni che vivono immerse nella natura, come i cacciatori-raccoglitori, al mutare al comportamento degli animali terrestri e marini che ha fornito i segni premonitori della catastrofe
[3] in realtà, almeno sulla base dei dati disponibili in epoca storica, alluvioni, tornado, siccità e altri fenomeni atmosferici sono responsabili di più morti globali che non la somma dei fenomeni tellurici e vulcanici e delle loro conseguenze (frane, maremoti, …). Tuttavia gli eventi atmosferici sono più frequenti e la loro dannosità per singolo evento più bassa. Sono fenomeni che ci sono relativamente familiari, mentre il terremoto è raro e spettacolare e più micidiale per singolo evento. E ' un po' come per gli incidenti aerei, che spaventano perché ognuno di essi causa la morte simultanea di decine o centinaia di persone, pur essendo il trasporto aereo molto più sicuro di quello automobilistico, che uccide poche persone alla volta ma si ripete con frequenza elevatissima
[4] il racconto di Strabone è confermato da Diodoro Siculo (90-27 a.C.): in una sola notte la prospera città greca di Helike (oggi Elice), citata da Omero nell'Iliade, sprofondò interamente nel mar Egeo, colpita da un terremoto che si stima essere stato di magnitudo 6.5-7 sulla scala Richter e dal conseguente maremoto. Il filosofo Eratostene e il viaggiatore Pausania asseriscono di aver visto verso il 150 d.C.. i resti sommersi della città che - a quanto sembra - era stata più volte colpita da terremoti precedenti e sempre ricostruita. Solo recentemente gli archeologici li hanno individuati
[5] si racconta che perfino prima dell'eruzione del Vesuvio (79 d.C.) furono segnalate irrequietezze degli uccelli e altri animali e si attribuisce questa narrazione a Plinio il Giovane, che assistette di persona all'eruzione (durante la quale perse la vita suo zio, Plinio il Vecchio). Tuttavia cercando nelle fonti si scopre che nelle celebri lettere a Tacito (Epistulae IV e VI), nelle quali Plinio racconta con dovizia di particolari - e prosa drammatica - gli eventi, non si parla assolutamente di animali. Ciò nonostante le successive cronache medioevali riportano di irrequietezza di cavalli, cani e altri animali prima dell'eruzione
[6] fu un terremoto devastante di magnitudo stimata non inferiore al grado 7,7 della scala Richter. Interessò una superficie di 10 milioni di kmq e fu avvertito in tutto il Mediterraneo e, nell'Atlantico, dall'Irlanda alle Barbados. Il successivo maremoto e gli incendi che divamparono distrussero l'85% della città di Lisbona e uccisero tra 60.000 e 90.000 persone su una popolazione di circa 275.000 abitanti. La gestione della catastrofe venne affidata al capo del governo, il marchese di Pombal, abilissimo riformatore di idee illuministe. Sua è la celebre frase E agora? Enterram-se os mortos e cuidam-se os vivo ("E allora? seppelliamo i morti e pensiamo ai vivi"): e infatti ricostruì gran parte della città in un anno (!)
[7] è necessario anche valutare le conseguenze sociali ed economiche della previsione. Tutti vorrebbero essere messi in allerta di fronte a un pericolo, ma se l'evento non si verifica l'allerta può avere conseguenze negative. Un caso che ha fatto scuola è quello di Pozzuoli del 1983-84: di fronte a un imponente bradisismo, con sollevamento del suolo fino a quasi due metri, 40.000 abitanti furono evacuati (si costruì addirittura un nuovo villaggio, Monterusciello, per ospitarli) in attesa di un'eruzione che non si verificò, con conseguente spopolamento permanente del centro storico di Pozzuoli. Casi analoghi si sono verificati anche altrove nel mondo
[8] secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INVG), negli ultimi 30 anni la Rete Sismica Nazionale ha registrato più di 190.000 eventi sismici in Italia e nei Paesi confinanti, la maggior parte dei quali non è stata avvertita dalla popolazione, mentre sono stati finora 45 i terremoti che hanno avuto una magnitudo Richter pari o superiore a 5.0.
[9] come osservato nella precedente nota 3 le catastrofi prodotte dall'acqua sono complessivamente più gravi di quelle generate dai movimenti tellurici. Si stima che la maggiore sia stata l'alluvione del fiume Yangtze-Huai che nel 1931 costò la vita a quasi 4 milioni di persone